La Corte Suprema ha ribaltato il verdetto di appello, ristabilendo quanto deciso dal giudice di primo grado.
Al medico dell’emergenza che giunge sul luogo della chiamata e non esegue la rianimazione cardiopolmonare su un soggetto colpito da infarto perché ritiene che ormai il abbia poche possibilità di salvarsi non è addebitabile l’omicidio colposo. La sentenza 41893 dell’11 ottobre 2019, emessa dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ha contro-ribaltato con l’assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) il verdetto di colpevolezza a opera della Corte d’appello, che dopo l’assoluzione del Tribunale in primo grado aveva condannato un medico a un anno di reclusione, con i benefici della sospensione e della non menzione, e al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede.
Il fatto – Il medico del 118, intervenuto in via d’urgenza per il malore (infarto) avvertito da un uomo, ometteva di compiere le manovre di rianimazione necessarie. Il paziente moriva a seguito di insufficienza cardiaca acutissima da miocardiosclerosi e stenosi di un ramo coronarico del ventricolo destro con aritmia, asistolia e ischemia miocardica per spasmo coronarico.
La sentenza di primo grado – Esiste un nesso di causalità tra l’omissione dell’imputato e il decesso della vittima? Domanda legittima, atteso che la rianimazione cardiopolmonare avrebbe attribuito alla vittima una possibilità di sopravvivenza tra il 2 e l’11%. Il giudice di primo grado aveva deciso per l’assoluzione, ritenendo che il medico, intervenuto sul posto 20-25 minuti dopo la chiamata, quando il decesso era già avvenuto (elettrocardiogramma piatto, assenza di parametri vitali, mitriasi fissa, perdita di urine e di feci per mancanza di impulsi elettrici che arrivano dal cuore), si fosse attenuto ai protocolli nazionali e internazionali, avendo appunto accertato la morte clinica del paziente.
La sentenza di secondo grado – Il giudice di appello aveva invece deciso per la condanna, sottolineando che l’ambulanza era giunta sul luogo circa otto minuti dopo la chiamata e che, secondo quanto riferito dalla convivente della vittima, poco prima l’uomo era cosciente e respirava, anche se male. Se fossero state effettuate le procedure per mantenere una ossigenazione di emergenza, sarebbe stata scongiurata con buona probabilità la progressione verso un danneggiamento irreversibile dei tessuti e degli organi (“la sopravvivenza a lungo termine nell’arresto cardiocircolatorio extra-ospedaliero riguarda, nel lasso temporale di un anno, il 74% dei pazienti… La totale assenza di manovre rianimatorie privò il paziente della possibilità di sopravvivere, stimata in un arco tra il 2 e l’11 % e, solo in caso di emersione di ritmo defibrillabile, in circa il 23% di tali chanches”).
La sentenza della Cassazione – La Suprema Corte ha infine deciso per l’assoluzione, affermando il medico d’urgenza non ha commesso omicidio colposo e che la Corte d’appello ha sbagliato a riformare l’assoluzione pronunciata in primo grado. La regola da applicare è quella del giudizio controfattuale: il nesso di causalità tra omissione dell’imputato e morte del paziente deve essere riscontrato in base a un giudizio di alta probabilità logica; non solo, quindi, in base a un ragionamento deduttivo fondato su generalizzazioni scientifiche, ma anche in base a un giudizio induttivo, elaborato sul fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
Si legge infatti nella sentenza: “In definitiva, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica; sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.
E ancora: “Deve osservarsi che sarebbe superfluo accertare se l’imputato sia giunto sul posto prima o dopo la morte del paziente, visto che si evince dalla sentenza impugnata che il suo intervento, in considerazione delle cognizioni mediche e delle circostanze del caso concreto, non avrebbe potuto salvarlo con l’alto grado di credibilità razionale, e cioè di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza richiesto, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del nesso causale”.
Inoltre: “Occorre sottolineare che, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, si riscontra comunque l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito, laddove gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione da parte del giudice sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’ che a un atto di ‘apprezzamento’, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”.
Secondo la Corte di Cassazione, infine, sono pure contraddittorie le dichiarazioni dell’unica testimone, ossia la convivente della vittima. Dalla sentenza di primo grado si evince che, quando partì la telefonata al 118, l’uomo aveva già perso conoscenza. Dalla pronuncia d’appello emerge invece che la vittima era cosciente, anche se respirava male.
Redazione Nurse Times






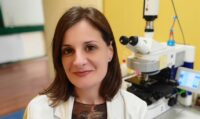







Lascia un commento