
In tema di responsabilità sanitaria, l’inadempimento contrattuale del sanitario deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale e non desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente. Da notare come sia complesso l’iter che conduce alla quantificazione dei danni patiti di natura patrimoniale e non patrimoniale.
In tema di responsabilità medica, la Suprema Corte, nella sentenza n. 24801 del 5 novembre 2013, è nuovamente investita della questione delicata in ordine al profilo dell’inadempimento del sanitario nei confronti del cliente-paziente. In particolare, ci si domanda se l’inadempimento del sanitario debba essere parametrato sulla base degli interessi, dei bisogni e delle speranze del cliente-paziente (e quindi delle sue aspettative) o più sui doveri inerenti allo svolgimento professionale in riferimento al caso concreto.
Un’anziana signora viene condotta all’Ospedale Oftalmico di Torino dopo un intervento alla cataratta dell’occhio destra, eseguito ventisei giorni prima in un clinica privata. Il suddetto intervento fallisce miseramente a seguito di un’emorragia espulsiva che comporta una totale e invalidante cecità dell’organo visivo. Già priva della funzionalità dell’occhio sinistro, in totale stato di cecità permanente ed invalidante, l’anziana donna decide di intervenire giudizialmente per chiedere un ristoro economico di natura risarcitoria (patrimoniale e non patrimoniale anche nei profili del danno morale ed esistenziale). Il primo grado di giudizio vede respingere la domanda, mentre il secondo grado vede vittoriosa la parte attorea. Nel corso del processo parte ricorrente muore e subentra la figlia.
Errata la condanna al risarcimento dei danni in favore della figlia?
Il primo profilo principale che emerge prepotente dall’analisi della Suprema Corte è di natura processuale. Infatti, emerge che la condanna al risarcimento dei danni in favore della figlia è errata sotto tale analisi perché: «il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie; ne deriva che, anteriormente alla domanda di riduzione, l’erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale instaurato, poiché l’unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. è il successore a titolo universale».
A ciò ne deriva una questione nettamente secondaria e del tutto inutile da trattare per il caso in esame, in ordine al primo punto ed afferente al tentativo di farsi riconoscere delle spese mediche non contestualizzate e non oggetto della domanda, per questo non ammissibili. Sul riconoscimento del quantum dei danni esistenziali patiti. Il secondo profilo principale che emerge è di natura squisitamente tecnica. Infatti, la questio iuris riguarda il riconoscimento del quantum dei danni esistenziali patiti dall’anziana signora: ad avviso della Corte, coerentemente con i precedenti indirizzi, non ci sono prove dedotte che consentano di far comprendere in che cosa consistano e quale possa essere la loro determinazione, tenuto conto che per danno esistenziale s’intende quella particolare (e recentissima) ricostruzione giurisprudenziale che individua il danno (esistenziale) nella più ampia categoria dei diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti dalla Carta Fondamentale e attinenti alla persona umana; in quest’ambito sarebbero, dunque, ricompresi il diritto alla corretta informazione, soprattutto in ambito medico, il diritto alla famiglia e tanti altri. Allo stato attuale è, tuttavia, dubbio quale sia il criterio idoneo a selezionare i beni-interessi idonei a giustificare la tutela giuridica e non è chiaro, poi, neanche quale sia il criterio da utilizzare per quantificare e qualificare la tipologia di danno alla persona in esame.
Il danno esistenziale, in riferimento alle sentenze della Consulta (n. 233/2003) e della Cassazione (nn. 8827-8828 del 2003), «…consiste nella lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, sconvolgendo nel complesso le attività areddituali del soggetto leso». In sostanza, per la Corte non è centrale il mancato riconoscimento di un danno esistenziale (nel caso specifico) quanto la mancata prova di aver subito un danno, tale da aver comportato un radicale cambiamento in negativo negli stili di vita precedenti all’intervento infelice. Sulla responsabilità medica.
Il terzo profilo principale che emerge è di natura giuridica. Infatti, emergono in chiave unitaria tutti i principi in tema di responsabilità medica partoriti dalla Suprema Corte negli ultimi anni. E proprio nell’ottica di rispondere al quesito se l’inadempimento del professionista debba essere o meno parametrato sui bisogni sulle necessità e sulle aspettative del cliente-paziente o più sugli standards qualitativi e sui doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale in riferimento al caso concreto, la Corte segue un filo logico dettato da tutti i principi di diritto del tema in esame. Prima di tutto viene messa in risalto la centralità del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. che (come un filo conduttore) segna tutto il percorso del rapporto di causalità tra azione (condotta) ed evento dannoso, tenuto debitamente conto che una causa autonoma e successiva che si inserisce nel processo causale in modo anomalo ed imprevedibile può spezzare il nesso e quindi far cadere l’imputazione, secondo il disposto degli artt. 40 e ss. c.p. e secondo il criterio della condicio sine qua non temperato dall’applicazione delle leggi scientifiche. In tal senso, infatti, come sancito dall’art. 40, comma 1, c.p., il nesso o rapporto di causalità è il legame di stretta connessione tra condotta ed evento, per cui: «Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione». Negli anni si sono succedute diverse teorie condizionalistiche, cioè teorie causali che legano la condotta di un determinato soggetto alla realizzazione di un determinato evento.
Madre primordiale di tutte le teorie è rappresentata dalla teoria condizionalistica o teoria della condicio sine qua non, per cui c’è un legame causale se l’azione (condotta) A è causa dell’evento B e senza l’azione A, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, l’evento B non si sarebbe mai verificato. Tale teoria muove dalla premessa che ogni evento è la conseguenza di molti fattori causali, che sono tutti egualmente necessari affinché l’evento si verifichi: causa dell’evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente sulla base di leggi scientifiche, senza che l’evento concreto venga meno (cd. procedimento dell’eliminazione mentale).
Il giudice, per accertare la sussistenza del nesso causalità, dovrà effettuare un giudizio contro fattuale: verificherà se, eliminando quel comportamento umano, l’evento concretamente realizzatosi si sarebbe verificato ugualmente (se la risposta è positiva, il nesso causale è escluso e quindi non ci sarà modo di addebitare alcuna responsabilità giuridica; se è negativo, il nesso causale è affermato e quindi è anche confermata la responsabilità giuridica addebitata in sede processuale). I corollari della teoria in esame sono:
a) il concorso di fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti non esclude il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento, quando l’azione è una condizione necessaria dell’evento (e ciò vale anche se i fattori estranei all’opera dell’uomo sono anormali o rari);
b) il rapporto di causalità non è escluso nemmeno se il fattore causale ulteriore rispetto all’azione dell’uomo consiste in un fatto illecito di un terzo;
c) il rapporto di causalità non sussiste quando tra l’azione e l’evento si è inserita una serie causale autonoma, che è stata da sola sufficiente a causare l’evento: in tal caso, l’azione (se tale azione costituisce per sé reato si applica la pena per questo stabilita) è solo un antecedente temporale, e non una condicio sine qua non dell’evento.
Null’altro, nei temi fin’ora affrontati dal presente commento, la Suprema Corte si sente di poter esprimere essendo di legittimità e non di merito. Continuando il percorso tracciato dal testo letterale, si consolida l’indirizzo secondo cui la responsabilità dell’ente ospedaliero è responsabilità di natura contrattuale (c.d. Contratto di Spedalità, Cass. n. 577/2008) e a sua volta l’obbligazione del professionista sanitario è della stessa natura (quindi, contrattuale), sia esso dipendente di una struttura pubblica o di una struttura privata. Pertanto, in base alla regola sancita dall’art. 1218 c.c.:«il cliente-paziente-creditore ha il mero onere di allegare il contratto e il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico o della struttura sanitaria o la relativa gravità» (Cass. n. 12274/2011).
Al debitore, invece, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, secondo il principio di vicinanza della prova, cioè il professionista è tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza qualificata della specifica attività esercitata (artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.), secondo i profili della colpa grave o del dolo, nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza professionale qualificata (quest’ultima sicuramente afferente alle prestazioni offerte da un professionista sanitario specializzato).
Ed è palese, secondo la Corte e secondo il parere dello scrivente che la condotta del primario di Oftalmologia, nell’occasione specifica di un intervento di routine, è stata gravemente colposa, sia sotto il profilo della negligenza grave sia sotto il profilo dell’imperizia e delle regole normali di cautela, potendo intervenire con una vitrectomia che sul piano diagnostico postumo avrebbe potuto comportare la rimozione dei residui del cristallino e il recupero per lo meno parziale del visus da parte del paziente, tenuta conto della completa cecità dell’occhio sinistro.
L’inadempimento contrattuale del sanitario va valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento della professione.
A fronte di quanto espresso e del palese concorso tra struttura sanitaria e professionista nell’aggravamento degli esiti infausti dell’evento verificatosi in corso di intervento chirurgico, con la conseguente irreversibilità del danno fisico e psicologico patito, la Corte ritiene soddisfatti i requisiti che confermano la negligenza e l’imperizia e, quindi, la fondatezza del profilo di colpa nella condotta in esame. E’ chiaro così ritenere che l’inadempimento contrattuale del sanitario deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale e non desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, anche se questi ultimi profili possono aiutare ad adempiere l’obbligazione nel modo migliore secondo i criteri di diligenza specializzata e diligenza qualificata dell’art. 2236 c.c. già richiamata.






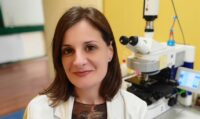







Lascia un commento