Ammalarsi gravemente in Italia significa ancora confrontarsi con un sistema sanitario disomogeneo. In terapia intensiva la qualità dell’assistenza non dipende solo dalla competenza dei professionisti – che resta elevata in molte realtà del Paese –, ma da un’organizzazione frammentata, in cui ogni Regione e spesso ogni singolo ospedale decide autonomamente come strutturare i propri reparti.
Standard nazionali vincolanti, di fatto, non esistono. Le regole comuni nemmeno. Il risultato è una sanità a “geometria variabile”, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei pazienti e sulle condizioni di lavoro degli operatori.
Trentasei anni senza una bussola
L’ultimo riferimento normativo sui rapporti tra personale infermieristico e pazienti critici risale al Decreto ministeriale del 13 settembre 1988. Prevedeva una dotazione di 24 infermieri per 8 posti letto di rianimazione, equivalente a un rapporto teorico di 1:1. Quel parametro, però, non è mai stato reso vincolante. È rimasto un riferimento programmatorio, oggi superato dalle evidenze scientifiche e inadeguato a rispondere alla complessità dell’assistenza intensiva moderna.
In assenza di standard nazionali obbligatori, le Regioni hanno costruito nel tempo modelli organizzativi differenti. Dati e monitoraggi istituzionali disponibili negli ultimi anni mostrano una marcata variabilità territoriale: in alcune realtà il rapporto infermiere-paziente risulta più favorevole, in altre peggiora sensibilmente, soprattutto nei turni notturni e festivi. Spesso non per una valutazione clinica, ma per scelte organizzative legate al contenimento dei costi.
Turni lunghi, rischi concreti
A complicare ulteriormente il quadro c’è la diffusione dei turni di 12 ore nelle terapie intensive. Una prassi ancora molto presente, ma tutt’altro che neutra. La letteratura scientifica evidenzia come i turni prolungati in contesti ad alta intensità assistenziale aumentino il rischio di errore clinico e favoriscano le cosiddette “cure mancate”.
Negli infermieri di terapia intensiva, la fatica fisica e mentale accumulata riduce progressivamente la capacità di vigilanza e incide sul benessere psicofisico. Eppure, nonostante evidenze ormai consolidate, questa organizzazione persiste in molte strutture, sostenuta dalla carenza cronica di personale e dalla difficoltà di garantire coperture adeguate.
I posti letto promessi e mai completati
La pandemia da Covid-19 ha messo in luce tutte le fragilità del sistema. Prima dell’emergenza, l’Italia disponeva di circa 8,5-9 posti letto di terapia intensiva ogni 100mila abitanti, un valore nettamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei. Il Decreto Rilancio del 2020 aveva fissato l’obiettivo di portare questo numero a 14 per 100milaabitanti.
A distanza di anni l’incremento è stato solo parzialmente realizzato e in modo disomogeneo. Alcune Regioni hanno raggiunto o quasi raggiunto i target previsti, altre sono rimaste indietro. Il problema non è solo strutturale: creare nuovi posti letto è inutile, se mancano anestesisti e infermieri adeguatamente formati per gestirli. Parte degli interventi è confluita nei progetti Pnrr, con scadenze spostate al 2026, ma il ritardo accumulato resta significativo.
Linee guida che restano sulla carta
La frammentazione non riguarda solo numeri e risorse, ma anche un aspetto cruciale: l’uniformità delle pratiche cliniche. Le società scientifiche SIAARTI e ANIARTI pubblicano linee guida aggiornate su temi fondamentali come sedazione, ventilazione meccanica, sepsi e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Rappresentano il riferimento scientifico più autorevole disponibile in Italia.
Il problema è che la loro applicazione rimane volontaria. Dipende dalle scelte delle singole aziende sanitarie e dalle risorse disponibili. Non esiste un obbligo di conformarsi a questi standard, né un sistema di monitoraggio capillare che ne verifichi l’attuazione.
Il progetto GiViTI dell’Istituto Mario Negri offre uno spaccato significativo di questa realtà. Coinvolge circa 200 terapie intensive e mostra come strutture anche geograficamente vicine possano adottare approcci diversi nella gestione delle stesse patologie: protocolli di sedazione differenti, strategie di svezzamento variabili, criteri di allerta applicati in modo disomogeneo.Gli stessi dati evidenziano che l’adesione alle linee guida basate sull’evidenza è associata a migliori outcome clinici. Il paradosso è evidente: ciò che funziona resta facoltativo.
Una questione di equità
Alla base di questa situazione c’è il federalismo sanitario introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione. Alle Regioni è stata attribuita la competenza esclusiva sull’organizzazione sanitaria, mentre allo Stato è rimasta la definizione dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Nei fatti, questo ha prodotto sistemi sanitari regionali molto diversi per risorse e performance.
Ridurre le disuguaglianze nella rete delle terapie intensive non è solo una scelta organizzativa, ma una questione di equità. Servono standard minimi nazionali vincolanti sui rapporti personale-paziente, dotazioni tecnologiche essenziali garantite ovunque e un reale riconoscimento delle competenze avanzate degli infermieri di area critica. Serve una rete integrata che colleghi terapia intensiva, pronto soccorso e territorio.
La terapia intensiva rappresenta l’ultima linea di difesa del sistema sanitario. Non può continuare a funzionare con regole diverse a seconda dell’ospedale o della Regione. La qualità delle cure non può dipendere dal luogo in cui ci si ammala.
Giuseppe Profilo
Articoli correlati
- Obesità, disponibile in Italia l’innovativo idrogel che aiuta a perdere peso
- Eutanasia e suicidio assistito: l’Europa si muove, l’Italia resta ferma
- FNOPI & Randstad: l’Italia “adotta” infermieri dall’estero. Valorizzare i giovani italiani, evidentemente, costava troppo
- Unisciti a noi su Telegram https://t.me/NurseTimes_Channel
- Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes
- Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi
- Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org
- Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari






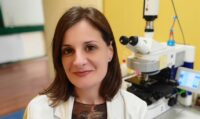


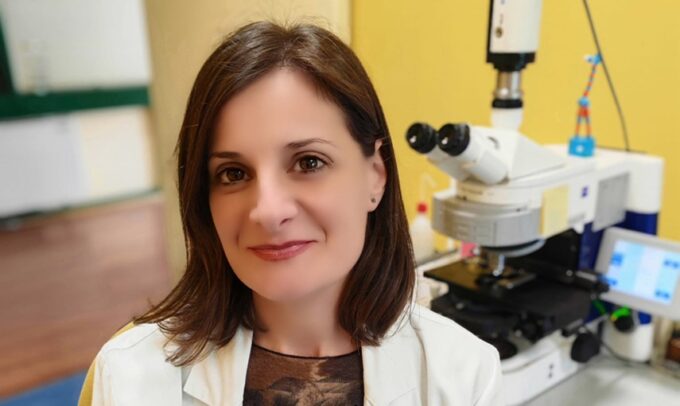


Lascia un commento