“SOTTO IL CIELO DI GAZA”
….raccontato dalla collega RENZA MARTINI, infermiera volontaria in Palestina riporta la sua esperienza sulla tragedia del popolo di Gaza, rapportandoci il dolore della guerra…IL SUO RACCONTO VERRA’ DIVISO IN 6 PARTI.
1. Primo giorno all’ospedale di Al Alawda
E’ il primo giorno sotto il cielo di Gaza, sono nella Striscia, Medio Oriente.
Oltre lo sguardo si stende il mare , tranquillo e azzurrino, sorvolato dai gabbiani.
Un pallido sole, oltre le nubi lontane, mi accompagna ad Al Alawda, dopo aver percorso strade, che non lo sono più, spesso solo mulattiere fangose e contorte, insidiose e instabili, per l’effetto subìto nei giorni addietro : pioggia di bombe e micidiali passaggi di tanks, le cui tracce e solchi, persistono sotto i miei piedi, assieme al sangue dei caduti, mischiato alla polvere.
Tutto intorno, ovunque lo sguardo mi si posi, cumuli di macerie indefinite.
Al Alawda: poco più che una palazzina di alcuni piani.
Definirlo ospedale è fin troppo gratificante. Circondato da fatiscenti strutture, non da meno un pollaio, dove le pecore belano assieme alle galline , sotto vecchi assi di legno, in un cortile sterrato.
Sarà il canto continuo del gallo che mi accompagnerà quotidianamente, nelle ore che alternerò fra lì e altri presidi ospedalieri, mentre mi troverò ad aiutare tante donne palestinesi a diventare madri.
Sentirsi infermieri in un tale contesto è pressochè riduttivo: mi accorgo infatti che, data la situazione di degrado del paese (vuoi per motivi politici, vuoi per motivi di guerra perenne), ed all’alba di un giorno d’inverno, dopo un massiccio attacco aereo, marittimo e terrestre, durato 22 giorni e 22 notti, chiamata Operazione “Piombo Fuso”, noi internazionali siamo accolti ovunque con entusiasmo e gioia, quale simbolo di una speranza di vita di un popolo oppresso.
Se poi si accorgono che siamo giunti fin lì, non solo per documentare una tragedia umanitaria, ma per entrare anche nelle loro case e in ciò che resta degli ospedali, per prendersi cura dei loro feriti, allora l’accoglienza di tutti, con centinaia di bambini urlanti e sorridenti che ci sommergono, si trasforma in una generale euforia , che mi ha portata a pensare: ….eppure sono “ solo “ un’infermiera!
Ma per questi poveretti è come se vedessero in questa figura un’ancora di salvezza, per l’immenso dolore che li sovrasta.
E così, quei piccolini che vedono la luce accompagnati dalle mie mani, su di un semplice e spoglio ripiano, privo anche di lenzuola, in quelle due stanzine che si affacciano sul pollaio, il cui primo vagito si mischia al canto del gallo, mi riflettono l’immagine di un mondo passato, un mondo in cui il tempo si è fermato, quando ancora alle infermiere non era stato insegnato di “ lavarsi sempre le mani” o “ usare i guanti” , per ogni pratica di contatto con liquidi organici; dove le donne, in procinto di diventare madri, sollevano il lungo vestito nero, quanto basta per dare spazio al bambino nell’uscire, rimanendo infagottate nei loro stracci casalinghi , e riabassando le vesti , una volta espletato il parto.
Altro che “camicia da notte”, altro che “contatto amorevole sul seno materno”, altro che attesa nel taglio del cordone ombelicale, per favorire il fluido magico che s’instaura col proprio bambino, nei primi attimi di vita, e prolungare così il contatto col ventre materno. Niente di tutto questo. E come se non bastasse, nemmeno la possibilità di ripulirsi dei liquidi del parto, che vengono piacevolmente assorbiti dalle lunghe tuniche palestinesi , e con cui se ne vanno tranquillamente via, dopo pochi minuti, col loro fagottino fra le braccia.

Le tre infermierine velate, Imaan, Sabreen e Amira, si dimostrano molto incuriosite dai miei gesti igienici, perlomeno tentativi di pulizia, tant’è che mi sorridono ma contemporaneamente mi fanno segno di scorrere: lì, “usa” così, senza tanti “preamboli”. Non solo, ma mi abituerò anche a vederle “sparire” ogni tanto, almeno 5 volte al giorno, quando si alzerà nel cielo il lamento del Muezzin, e loro, alternandosi, s’inginocchieranno su di un polveroso e consunto tappeto, in un angolino dietro una porta, per pregare.
Eppure ho imparato io, qualcosa: la naturalezza primitiva, con cui si viene alla vita, al di là di ogni progresso professionale, di ogni clausola igienica e preventiva, che fanno nella nostra professione la colonna portante dell’assistenza infermieristica.
Ho imparato a trascurare tante manovre di approccio e di contatto, sia con la partoriente che col neonato: la madre che non si spoglia e che non viene pulita; il piccolo che, una volta appoggiato sul piccolo ripiano, sotto quella misera lampada che emana calore (a ricordarmi le lampade usate da mia madre, durante la mia infanzia, nelle gabbie del mio vecchio pollaio, in campagna, sui nidi di uova, onde riscaldarle e fare nascere i pulcini, in mancanza della chioccia) spandendosi tutt’intorno, anche su chi è lì vicino, in pochi minuti il bebè viene avvolto da più coperte di grossa lana colorata, senza né essere lavato, né tantomeno il cordone ombelicale isolato e disinfettato.
Dopodichè si forma un “fagottino” (con un metodo insegnatomi dalle donne palestinesi), in cui le braccine dei neonati vengono alternativamente allungate lungo i fianchi e fissate, come un salamino.
E poi di corsa, fra le braccia della mamma….e via.
Avanti un’altra, c’è la coda , fuori, neanche fosse un banale ambulatorio di visite.
E’ impressionante il numero di parti, solo ad Al Alawda si arriva a circa 15 al giorno, circa 500 al mese.
Ed è “solo” una palazzina, un “francobollo“ d’ospedale.
A pochi metri dai lettini di parto (chiamare Sala Parto quelle due stanzine, è complimento), si aprono le porte (a pensarci bene non c’erano porte) di piccole camerette fatiscenti, con due-tre letti ravvicinati, sempre separati da grandi e polverosi tendaggi (per garantire la privacy), non solo perchè uomini e donne sono assemblati, ma la religione stessa, a prescindere dai due sessi, impone alle donne assoluta riservatezza.
Tant’è che, nei piccoli ritrovi, dove si può consumare un pasto a base di “bite” (piadine rafferme riscaldate) e polpette di verdure, o chissà mai cosa c’è dentro, e creme di ceci, diversi tavoli sono circondati da tendaggi polverosi, entro i quali famigliole intere con presenze femminili, delimitano i loro confini, isolandosi dagli astanti.






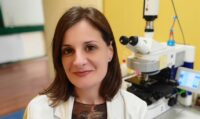







Lascia un commento