Interessanti risultati da uno studio sull’antibiotico-resistenza coordinato dall’Irccs Ospedale San Raffaele e supportato dall’Aifa.
Uno studio multicentrico internazionale coordinato dall’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha dimostrato come la somministrazione continua o intermittente di meropenem, antibiotico utilizzato per la maggior parte delle infezioni da gram negativi, appartenente al gruppo delle beta-lattamine e inserito nella lista dei farmaci essenziali dell’Oms, non incide sulla prognosi dei pazienti e getta nuova luce sulle politiche sanitarie da adottare per indirizzare risorse umane ed economiche in interventi di maggior efficacia.
La ricerca, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista Jama e supportata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è stata coordinata dai professori Alberto Zangrillo, Giovanni Landoni e Giacomo Monti, del Centro di ricerca in Anestesia e terapia intensiva dell’Irccs Ospedale San Raffaele e dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Ha coinvolto 26 ospedali in quattro nazioni diverse (Italia, Russia, Kazakhstan e Croazia), per un totale di 607 pazienti: la più grande popolazione di persone incluse in un progetto di ricerca su questo specifico tema.
La resistenza agli antibiotici, ovvero la capacità dei batteri di divenire insensibili all’azione dei farmaci in grado di ucciderli, rappresenta un’importante emergenza sanitaria. Si stima che negli Stati Uniti questi particolari batteri abbiano causato oltre 2,8 milioni di infezioni nel 2019 e contribuito alla morte di quasi 36mila persone.
Per questa categoria di antibiotici, le beta-lattamine, il modo in cui vengono somministrati, oltre che la dose e la selezione della particolare molecola, sono elementi fondamentali nel determinare l’efficacia della terapia e il rischio di insorgenza di nuove infezioni o sovra-infezioni.
Grazie all’esito di precedenti studi scientifici e a considerazioni di tipo farmacologico, si è sempre ipotizzato che la somministrazione “in continuo” di questi farmaci, tramite infusione endovenosa continua, rispetto alla classica somministrazione “intermittente”, sempre endovenosa, offrisse un vantaggio in termini di miglior sopravvivenza all’infezione e un minor rischio di insorgenza di batteri multiresistenti a svariati antibiotici. Tuttavia questa ipotesi non aveva mai trovato una conferma, o una smentita, all’interno di un grande studio scientifico.
Per queste ragioni il gruppo di lavoro coordinato dai professori Zangrillo, Landoni e Monti, ha elaborato, in un progetto iniziato oltre dieci anni fa, un protocollo di ricerca sperimentale in grado di rispondere in maniera efficace a questa domanda: qual è il modo migliore di utilizzare il meropenem nelle infezioni più severe, quelle che colpiscono malati ricoverati presso le unità di terapia intensiva?
Nello studio, condotto in cieco, sono stati presi in considerazione 607 pazienti affetti da una particolare forma di infezione grave (respiratoria, gastrointestinale o urinaria) al punto da determinare un quadro di sepsi, una particolare reazione del corpo alle infezioni che può causare morte in un paziente su tre.
Inoltre, proprio la peculiarità dell’infezione li esponeva a un elevato rischio di sviluppare una nuova, ancora più severa infezione, potenzialmente sostenuta da batteri con profili di resistenza ancora peggiori, anche a causa del trattamento antibiotico stesso. A metà di questi pazienti è stato somministrato meropenem in infusione endovenosa continua, mentre l’altra metà in infusione endovenosa intermittente.
Il trattamento somministrato con meropenem è risultato quantitativamente identico nei due gruppi, come quantità di farmaco complessivamente somministrato. I pazienti che hanno partecipato allo studio sono stati poi seguiti per i successivi 90 giorni per verificare se il trattamento ricevuto fosse in grado di modificare l’andamento della patologia.
In particolare, l’obiettivo primario del progetto era misurare il numero di pazienti che sarebbero andati incontro a morte o a una nuova infezione più difficile da trattare con antibiotici, durante il periodo di osservazione. Le infezioni che si sono sviluppate nell’arco del tempo di osservazione erano causate prevalentemente da un particolare tipo di batteri, detti gram negativi, quelli più spesso implicati nelle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, soprattutto in Europa e in Italia.
Fra questi, Klebsiella, Pseudomonas e Acinetobacter, i generi più spesso identificati e considerati dall’Oms come i più a rischio di sviluppare resistenze ai farmaci. Il risultato dello studio è stato neutro: in entrambi i casi la somministrazione sia intermittente sia continua ha prodotto il medesimo esito: la mortalità dopo 90 giorni è risultata essere identica nei due gruppi, attestandosi al 42%.
“Con questo studio abbiamo dimostrato che la modalità di somministrazione dell’antibiotico non è in grado di modificare in maniera significativa la mortalità o l’insorgenza di nuove infezioni ancora più difficili da trattare”, spiega Giacomo Monti.
“Durante lo studio, non è stato osservato alcun effetto collaterale legato all’infusione del farmaco in entrambe le modalità, e ciò rappresenta un importante indice di sicurezza per entrambi i sistemi di somministrazione”, aggiunge Alberto Zangrillo.
La ricerca ha infine mostrato che non esistono particolari nicchie di pazienti che potrebbero forse beneficiare di una modalità di somministrazione piuttosto che dell’altra. “I risultati della ricerca – continua Giovanni Landoni – spostano quindi l’attenzione su altri aspetti che si dovranno tenere in considerazione nella gestione del malato che presenta gravi infezioni batteriche in terapia intensiva, valutando di poter destinare risorse umane ed economiche ad altri specifici interventi che potrebbero essere di maggiore efficacia”.
Lo studio dei dosaggi, che potrebbero dover essere aumentati nelle prime ore, la durata della somministrazione, che potrebbe essere ridotta in casi selezionati e l’associazione di altri antibiotici, sono alcune delle specifiche importanti che vanno prese in considerazione. Ma non solo: la prevenzione delle infezioni stesse, con la riduzione dell’utilizzo degli antibiotici nella popolazione in generale, passa attraverso anche l’igiene delle mani degli operatori sanitari.
Conclude il professor Zangrillo: “Ci auguriamo che lo sviluppo di nuove tecnologie possa aiutare a ottimizzare le diagnosi delle infezioni, anticipandole e rendendole più precise e che, grazie all’utilizzo di farmaci e tecniche adiuvanti, si possano migliorare le capacità del sistema immunitario dei pazienti a reagire all’infezione, senza amplificare la risposta infiammatoria”.
Redazione Nurse Times
Rimani aggiornato con Nurse Times, seguici su:
Telegram – https://t.me/NurseTimes_Channel
Instagram – https://www.instagram.com/nursetimes.it/
Facebook – https://www.facebook.com/NurseTimes. NT
Twitter – https://twitter.com/NurseTimes
- Maternità non penalizza le lavoratrici: storica sentenza in favore di una Oss contro l’ASL di Taranto
- Recupero dopo ictus: decisivo il contributo dell’emisfero cerebrale opposto alla lesione
- Asst Gaetano Pini – CTO di Milano: concorso per un posto da infermiere pediatrico
- La sanità che apre concorsi come il supermercato apre casse
- Asst Gaetano Pini – CTO di Milano: concorso per 10 posti da infermiere






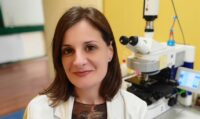


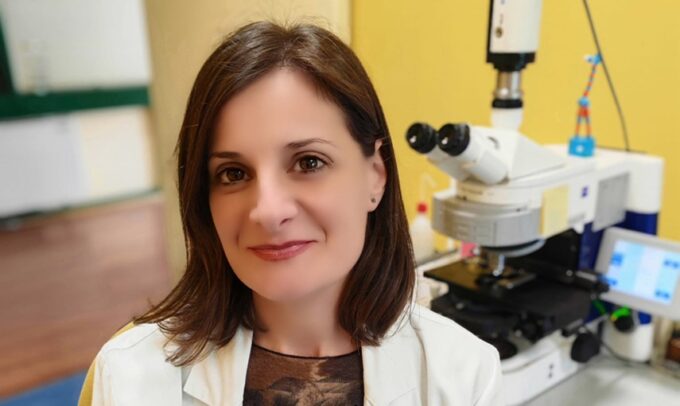


Lascia un commento