2. I primi feriti
Mi appaiono i primi feriti che, nonostante sia stato dichiarato il “cessate il fuoco” da dieci giorni, e l’emergenza del massiccio attacco sia oramai superato, ancora persistono qua e là, spesso avvolti in poveri stracci e grosse coperte di lana colorata, passate di paziente in paziente, e forse mai lavate.
Mi sono chiesta spesso, inopportunamente date le circostanze, chissà mai se esisteva un protocollo per le infezioni ospedaliere.
Pensavo al “nostro Clostridrium“, e alla “nostra Legionella”, in compagnìa dello “Streptococco”, se mai conoscevano quei luoghi medio-orientali; o se quantomeno il vento del Sinai, soffiandoli oltre il deserto, mosso a pietà, avesse avuto l’accortezza di risparmiare quella terra e quei derelitti da un simile contagio.
Alternando turni di attività da un presidio all’altro, giungo ad Al Shifa, l’ospedale centrale di Gaza city, dove i segni del bombardamento si presentano fin dal piazzale antistante l’ingresso: due ambulanze lasciate lì, a cuocere sotto il sole, che già accende il cielo di un fine gennaio, sono solo ammassi di lamiere contorte, silurate da carri armati, dove i resti dei corpi disintegrati e appiccicati ovunque, appaiono ai miei occhi come disegni di una funesta tappezzeria, che nessuno ha provato a rimuovere; ci pensa un gattino, a leccare le lamiere, per poi riposarsi sul sedile accartocciato, incurante del mondo intorno.
Poco distante, un cumulo di macerie, che mi dicono essere stata la Moschea dell’ospedale, mi fanno fremere di timore; non è difficile intuirlo: decine di tappeti multicolori sono distesi alla belle meglio sui calcinacci, e sopra, coi piedi scalzi, i fedeli pregano, inchinandosi al Muezzin.
Entrando in Al Shifa, mi assale una sensazione di estrema impotenza e vulnerabilità, di fronte ad un pericolo occulto, che non è più, in questo contesto, rappresentato da germi e batteri che provocano malattie e loro complicanze, infezioni ospedaliere e chirurgiche; come non è più prioritario pensare all’igiene ambientale e alla prevenzione: no, prevale sopra ogni cosa la consapevolezza della precarietà della vita stessa, dovuta essenzialmente all’interagire di “semplici” esseri umani , che decidono della vita e della morte di loro simili .
Qui tutto si capovolge: ed ecco il primo contatto con i feriti “veri”, amputati, politraumatizzati, quando non colpiti o sventrati da proiettili, o schiacciati sotto le macerie.
E quei poveri corpi ustionati, di cui mi verrà detto: “sono strane ustioni, non sappiamo cosa fare, dove mettere le mani, mai visto niente di simile, dopo giorni e giorni la carne continua a bruciare, fino a divorare i corpi, basta sollevare le bende e i tessuti riprendono a fumare… Al contatto con l’acqua, aumenta e peggiora la situazione. Abbiamo solo capito che è il contatto con l’ossigeno che fa riprendere vita al fuoco, basta un 10 % di contatto in un corpo, per decretarne la morte”.
Tanti ustionati, dopo un primo soccorso, sono stati rimandati via, al loro destino; per vederli poi ritornare dopo pochi giorni, aggravati, con la carne delle ferite consumata fino all’osso, e gli organi interni compromessi.
Finchè hanno compreso che dovevano rimuovere chirurgicamente le parti ustionate, per asportare ogni frammento, anche microscopico, della sostanza micidiale: il “ fosforo bianco”.
Parlo col dottor Ahmed, dell’ospedale di Al Shifa, dove c’è un via vai di madri in nero, mogli, sorelle, figli che strisciano per corridoi e corsie ad assistere i divorati dal fosforo e dalle DIME ( Dense Inerte Metal Explosive); mi conferma quanto già sentito: dopo una laparatomia primaria per ferite che parevano relativamente piccole e poco contaminate, un secondo intervento ha rivelato aree crescenti di necrosi, dopo un periodo di tre giorni.
Poi la salute si deteriora ed entro dieci giorni necessita un terzo intervento, che mette in luce una massiccia necrosi del fegato o di altri organi.
Il fenomeno è accompagnato da emorragie diffuse , collasso renale, infarto.
Spesso questi feriti sono giunti a cercare soccorsi portati a spalla, o su carretti trainati da asinelli , dove venivano sdraiati e ammucchiati adulti e bambini.
Crani fracassati, occhi letteralmente saltati fuori dalle orbite (da racconti di parenti) che penzolavano sul viso, ma respiravano ancora, e la speranza non moriva.
Una madre distrutta, urlando di disperazione, ci trasmette il suo dolore, parlandoci del suo bambino: “aveva il torace aperto, gli si potevano contare le costole bianche”… mentre lei teneva appoggiate le mani su quel petto scoperchiato, come se cercasse di aggiustare quel frutto del suo amore, e prolungarne la vita, oramai inutilmente volata oltre il mare.
Incomincia così, prima ancora del mio contatto fisico, nell’adoperarmi con quel poco di materiale a disposizione che mi ritrovo, il mio contatto umano, emotivamente sconvolto da quegli abbracci disperati di madri e padri sconosciuti, da quelle frasi arabe per me incomprensibili, urlate più che raccontate; ma più che altro da mille occhi scavati dal dolore, che dicevano tutto, prima ancora delle parole: non importava conoscere la lingua.









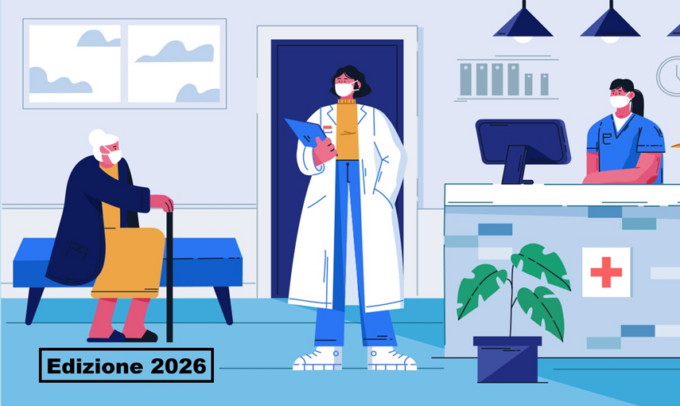




Lascia un commento